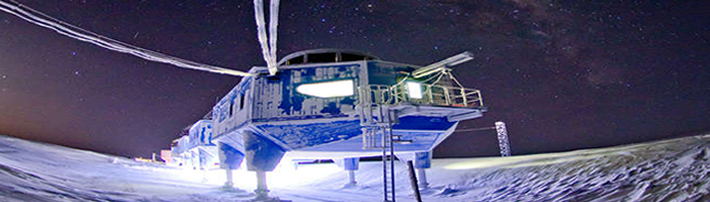Parere Pro-Veritate, principi di: autodeterminazione, erga omnes, jus cogens.
LINARES ASSOCIATES PLLC
International Business Law Firm
L’Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 21-02-1968, ha ratificato la convenzione di New York del 10-06-1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, a decorrere dal 1° maggio 1969.
1) Conformità giuridiche delle 2 sentenze di cui trattasi.
L’articolo 1, paragrafo 2, di detta convenzione testualmente recita: “Per sentenza arbitrale si intendono non soltanto le sentenze rese dagli arbitri nominati per casi determinati ma anche quelle rese dagli organismi permanenti di arbitrato ai quali le parti si sono sottoposte”. Per questi motivi, il termine “sentenza” usato negli arbitrati internazionali amministrati dalla Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa trova la sua legittimità nella Legge italiana di ratifica e di esecuzione della convenzione di New York del 10-06-1958, ossia nella Legge 19-01-1968 n. 62.
Ne deriva l’ulteriore possibilità di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958.
Inoltre, il ruolo delle camere arbitrali è previsto dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e della legge di riforma del diritto dell'arbitrato italiano del 2006. L’art. 832 del codice di procedura civile, primo comma, prevede, in proposito, che la Convenzione d’arbitrato può fare rinvio ad un regolamento arbitrale precostituito. L’articolo di cui sopra detta alcune disposizioni generali per il caso, in cui le parti si affidino ad una istituzione, che organizza l’arbitrato.
Vale la pena sottolineare, altresì, come, ad esempio, le sentenze pronunciate dai tribunali della Corte Superiore di Giustizia Arbitrale abbiano gli stessi effetti delle sentenze pronunciate dai tribunali ordinari della Repubblica italiana. I tribunali della Corte Arbitrale sono, infatti, organi di giurisdizione civile ordinaria, aventi, nella speciale materia, gli stessi poteri del giudice civile ordinario (Commissione Tributaria di II grado di Roma, 19-11-1984, Temi Romana 1984, 913, e Cassazione 22-10-1991 n. 11197, Foro it. 1991, I, 701). La sentenza pronunciata dai giudici dell’arbitrato, quindi, “è una vera e propria sentenza emessa nell’esercizio di una funzione giurisdizionale di cognizione ordinaria” (Corte di Appello di Roma 18-2-1969, rep. Foro it. 159 e n. 88). Dopo la riforma del 2006, i suddetti orientamenti giurisprudenziali della teoria processualistica della convenzione arbitrale, sono stati recepiti dal legislatore italiano nel D. lgs 2 febbraio 2006, n. 40, con l’approvazione dell’art. 824 bis c. p. c. che testualmente recita: “… il lodo (sentenza arbitrale, n. d. r.) ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”. Anche se l’art. 824 bis c. p. c. usa la dizione lodo e non la dizione sentenza, sarebbe opportuno dopo la scelta processualistica del legislatore italiano del 2006, mutare il termine lodo con il termine sentenza arbitrale. La Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62, entrata in vigore il 1° maggio 1969 (G. U. R. I. n. 46 del 21 febbraio 1968), per sentenze arbitrali (art. 1 paragrafo 2) intende "le sentenze rese dagli arbitri". Secondo taluni giuristi, tra i quali il prof. Giuseppe Mirabelli, primo presidente emerito della Corte di Cassazione, non appare soddisfacente, vista la completa assimilazione della sentenza arbitrale alla sentenza ordinaria, il mantenimento del termine “lodo”, anche se il relatore del disegno di Legge sul diritto dell’arbitrato del 1989, definì la questione “meramente formale” (M. Rubino Sammartano, Il Diritto dell’arbitrato, III edizione, Cedam, 2002). Negli arbitrati internazionali il Tribunale Arbitrale nelle sue decisioni usa la dizione “sentenza”, come stabilisce la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata dall'Italia con legge n. 62/68, entrata in vigore il 1° maggio 1969.
2) sentenze importanti riprese da altri tribunali internazionali o pubblicate in testi di giurisprudenza.
Stati Uniti Corte d’Appello della Florida, 3° Distretto, Sentenza 1° maggio 2002, N. 3D00-657 Benefit Association International, Inc. vs. Mount Sinai Comprehensive Cancer Center
Oggetto: Arbitrato internazionale - Riconoscimento della Convenzione di arbitrato - Applicabilità della Convenzione di New York del 1958 e del US Federal Arbitration Act- Sede dell’arbitrato - Clausola selezione del foro - Contrarietà all’ordine pubblico - Onere della prova - Impugnazione del provvedimento di 1° grado - Annullamento parziale.
La determinazione convenzionale della sede dell’arbitrato si presume valida ed efficacie e deve essere resa esecutiva a meno che non ricorrano alcune particolari circostanze tra cui l’ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico. La compromissione di esigenze di ordine pubblico deve essere dimostrata in giudizio e a tal fine non è sufficiente rilevare l’assenza di collegamento tra la controversia e lo Stato eletto quale sede dell’arbitrato. A tal conclusione si perviene sia nel caso in cui si ritenga applicabile la Convenzione di New York del 1958 sia laddove si decida per l’applicazione del Florida International Arbitration Act.
La decisione in esame mette in particolare evidenza due problematiche concernenti la prima l’ambito di applicazione della Convenzione di New York del 1958, la seconda la discutibile possibilità per il giudice nazionale di censurare, in sede di riconoscimento dell’accordo compromissorio, la scelta compiuta dalle parti in lite circa l’individuazione della sede dell’arbitrato. Rispetto alla prima questione, è possibile sottolineare che se a New York si è stati molto attenti nel definire l’ambito operativo dell’elaboranda Convenzione con riferimento all’esecuzione del lodo arbitrale, la normativa concernente il riconoscimento degli accordi compromissori è stata oggetto di minore riflessione. E’ indubbio che le ragione vadano ricercate nei lavoratori preparatori, essendo noto che soltanto nella parte conclusiva dei lavori della Conferenza, si è deciso di abbondonare l’idea originaria basata sull’adozione di due Trattati distinti e al contempo di inserire nella Convenzione dedicata all’esecuzione del lodo straniero, un articolo che riguardasse la convenzione di arbitrato; era pertanto inevitabile che la normativa concernente i procedimenti di riconoscimento di tali convenzione risultasse per certi aspetti incompleta, e che un lavoro molto delicato in tal senso sarebbe affidato all’interprete. Essendo la disciplina convenzionale silente sul punto proprio all’interprete si chiede di verificare se la Convenzione di New York possa dirsi applicabile a quegli accordi compromissori che prevedano una sede arbitrale nel territorio dello Stato dove è invocato, oppure che non contengano disposizioni in merito alla scelta della sede: per il caso di cui si discute si rientra nella prima delle due ipotesi delineate, atteso che la clausola compromissoria inerente al contratto principale elegge quale sede dell’arbitrato la città di Jackson in Mississippi, mentre l’avvenuta conclusione dell’accordo compromissorio viene fatta valere in Florida. Premesso che sull’argomento è stato scritto molto da parte di autorevoli esperti della materia, è possibile sottolineare come, a prescindere dall’orientamento dottrinario a cui si intenda aderire, il risultato finale non cambia. La Corte d’Appello ritiene che la Convenzione di New York sia applicabile al caso di specie in quanto, il Federal Arbitration Act, nel rendere esecutiva nel territorio statunitense la disciplina convenzionale in oggetto, definisce il suo ambito operativo facendo riferimento alla internazionalità dell’arbitrato anziché alla nazionalità del lodo o dell’accordo compromissorio. In pratica, la scelta del legislatore americano è stata quella di favorire l’applicazione della Convenzione a tutte le ipotesi di arbitrato internazionale, la cui internazionalità può essere data, oltre che dalla diversa nazionalità delle parti, dalla transnazionalità oggettiva della controversia, senza che a tal fine possa assumere rilevanza la localizzazione geografica dell’arbitrato all’interno o al di fuori del territorio statunitense. La suddetta disposizione ha fatto molto discutere circa la sua compatibilità con il sistema normativo voluto e adottato a New York, soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore americano, nel richiamare la nazionalità delle parti quale criterio determinante l’internazionalità del lodo, ha reintrodotto un criterio discretivo volutamente scartato in Conferenza. Al di là della fondatezza o meno di tali critiche, l’idea della incompatibilità tra la Convenzione e la normativa di applicazione USA sembrerebbe reggere nell’ipotesi in cui un lodo o accordo compromissorio, estero rispetto ad un giudice americano , sia decisamente soggetto ex articolo I alla Convenzione di New York, ma ne rimanga fuori per la previsione della Sezione 202 del Federal Arbitration Act (perché, ad esempio, le parti provengono da dallo stesso Paese e/o la controversia non presenta momenti di collegamento significativi con altri ordinamenti nazionali); viceversa, più che di incompatibilità dovrebbe parlarsi di allargamento dell’ambito operativo della disciplina convenzionale, nel caso in cui un lodo o accordo compromissorio, seppur domestico rispetto al giudice nazionale statunitense, sia comunque inquadrabile nell’ambito di applicazione del Federal Arbitration Act e dunque della stessa Convenzione per il suo carattere internazionale. In sostanza, ciò che si cerca di affermare è che nella prima ipotesi verrebbero a essere sottratte alla Convenzione di New York situazioni, di fatto o di diritto, che la stessa è invece chiamata a disciplinare, non garantendosi, di conseguenza, la sua fedele esecuzione nell’ordinamento interno. Nella seconda ipotesi, invece, il suo ambito di applicazione verrebbe a essere allargato senza per ciò registrarsi implicazioni di sorta riguardo l’obbligo di esecuzione dei trattati internazionali: è come se il legislatore nazionale decidesse di dettare una disciplina normativa anziché ex novo, rinviando a una preesistente normativa convenzionale, opzione che ogni legislatore sembrerebbe libero di esercitare, quanto meno dal punto di vista del diritto internazionale. E’ proprio questa seconda ipotesi a concretizzarsi nel caso di specie: atteso che l’attività di assicurazione in oggetto è svolta dalla ricorrente a livello transnazionale e atteso che al momento della conclusione dell’accordo compromissorio una delle parti risiedeva a Panama, il rapporto litigioso presenta momenti di collegamento con diversi ordinamenti, quindi in virtù di quanto si legge nella Sezione 202 del Federal Arbitration Act e per le ragioni di cui sopra, la Convenzione di New York può dirsi applicabile. Fatta chiarezza sulla prima questione, resta da verificare se e in che misura il giudice nazionale possa sindacare, in sede di riconoscimento dell’accordo compromissorio, la scelta sulla sede dell’arbitrato espressa dalle parti in lite. Per il caso di cui si tratta, su proposta della società assicuratrice e con l’accettazione tacita dell’assicurato (che poi ha ceduto la sua posizione contrattuale a Mount Sinai), la sede dell’arbitrato è stata fissata nello Stato del Mississippi, nella città di Jackson. Il giudice di primo grado ha correttamente rinviato le parti davanti agli arbitri, ma ha imposto che l’arbitro si rivolgesse in Florida, essendo la scelta del Mississippi quale sede arbitrale contraria a ragioni di ordine pubblico. In sede di impugnazione, la Corte d’Appello ha parzialmente annullato, con la decisione in oggetto, la pronuncia del giudice di primo grado, facendo salva la scelta compiuta dalle parti circa la determinazione della sede, sulla base del seguente ragionamento: in virtù dell’orientamento della giurisprudenza seguito dalle corti statunitensi in tema di clausola sulla scelta del foro, una scelta negoziale delle parti in lite sulla definizione del foro competente si presume valida ed efficace e deve essere resa esecutiva a meno che non ricorrano circostanze specifiche. In particolare, il giudice può decidere di non garantire l’effettività di tale scelta qualora ci si trovi in presenza di:
- i) unreasonableness e unjustice nell’esercizio dell’azione giudiziale davanti al giudice;
- ii) eccessivo potere contrattuale o influenza indebita esercita da una delle parti sull’altra nella sottoscrizione dell’accordo;
- iii) frode esercitata da una delle parti nella determinazione del giudice competente;
- iv) tradizionali motivi di nullità del contratto;
- v) contrarietà a ragioni di ordine pubblico.
Proprio quest’ultimo motivo è stato fatto valere da Mount Sinai senza tuttavia risultare in grado di dimostrare, attraverso la produzione di adeguate prove in giudizio, la concreta presenza di una simile contrarietà. Tale prova non è stata, invece, fornita non potendosi, assolutamente, ritenere sufficiente a integrare la fattispecie di contrarietà all’ordine pubblico il fatto che Setton avesse compilato in lingua spagnola la domanda per ricevere poi una polizza assicurativa redatta in lingua inglese; o ancora il fatto che in Florida fossero situati gli uffici amministrativi dell’attore e che sempre in Florida Setton avesse ricevuto le cure mediche controverse, con la conseguente inesistenza di qualsivoglia collegamento del contratto oggetto della controversia con lo Stato del Mississippi. E’ inutile ricordare le implicazioni sottese alla scelta della sede dell’arbitrato, sia per quel che concerne gli interventi giudiziali a sostegno della procedura arbitrale, sia con riferimento a eventuali procedimenti di impugnazione e di esecuzione. Nella stessa Convenzione di New York, è proprio la sede il primo criterio utilizzato per determinare la nazionalità del lodo ed è di conseguenza proprio il concetto di sede a delimitarne in gran parte l’ambito di applicazione. E’ evidente, pertanto, che l’individuazione della sede non può che essere frutto di una decisione rimessa alla comune volontà delle parti, potendosi eventualmente prevedere la possibilità di un intervento esterno per il solo caso in cui i litiganti non siano in grado di pervenire ad una determinazione comune. Nel caso di specie, una scelta precisa, invece, c’è stata ma si è cercato di non farla valere in sede giudiziale richiamando un tipo di test, che le corti statunitensi hanno elaborato con riferimento a scelte negoziali di foro competente. In realtà, in tutti i casi menzionati dalla stessa Corte la giurisdizione di un giudice statale è stata convenzionalmente derogata a favore di un altro giudice statale e non a favore di un giudice privato. La stessa Convenzione di New York all’articolo II si limita ad imporre al giudice nazionale la sospensione del procedimento e il rinvio delle parti all’arbitro a meno che l’accordo compromissorio non sia nullo, invalido o non possa essere eseguito. L’indagine che il giudice nazionale è chiamato a svolgere, pertanto, sembrerebbe essere volta semplicemente a verificare l’esistenza di una convenzione di arbitrato e se la stessa sia sommariamente valida ed efficace, senza esserci spazio per un’indagine sul contenuto materiale dello stesso compromesso. Anche volendo collegare il contenuto dell’articolo II con quello dell’articolo V della Convenzione, che enuclea i motivi i motivi ostativi all’esecuzione del lodo arbitrale, la determinazione negoziale della sede dell’arbitrato non sembra censurabile sotto il profilo dell’ordine pubblico. E’ ormai opinione comune che nella determinazione della localizzazione geografica dell’arbitrato non è assolutamente richiesto un collegamento, seppur minimo, tra il rapporto giuridico litigioso e l’ordinamento prescelto, sicché immaginare una scelta tendenzialmente libera, e concepita come tale da molti sistemi giuridici nazionali, possano derivare compromissioni di sorta dell’ordine pubblico sembra quanto meno improbabile.
In ultima analisi, anche a fronte di una determinazione negoziale della sede dell’arbitrato, che possa dirsi lesiva di esigenze di ordine pubblico, il giudice nazionale, in sede di riconoscimento dell’accordo compromissorio, potrebbe soltanto decidere di non rinviare le parti agli arbitri, sul presupposto che per questo motivo l’intera convenzione risulterebbe invalida. Di sicuro non potrebbe, come ha preteso di fare nel caso in esame il giudice di I° grado, pretendere di determinare in positivo la sede dell’arbitrato. La nozione di ordine pubblico più che nel senso di limitare la volontà delle parti circa la localizzazione geografica dell’arbitrato, potrebbe essere utilizzata come criterio discernente le materie cosiddette compromettibili e anche sotto questo profillo appare pertinente fare riferimento ad alcuni recenti sviluppi giurisprudenziali. E’ noto che nei paese di civil law si tende a considerare non arbitrabile la controversia concernente materie che interessano l’ordine pubblico, in quanto la presenza di interessi superindividuali implica il sacrificio degli interessi personali realizzabili nel concreto esercizio dell’autonomia negoziale. Negli Stati Uniti, invece, è la stessa autonomia privata ad assumere rilevanza pubblicistica e pertanto i limiti all’area del compromettibile non nascono dal sacrificio dell’interesse privato in nome di quello pubblico, bensì dal contemperamento dei due diversi interessi, entrambi di rilevanza pubblicistica, che sono l’autonomia negoziale da una parte e l’ordine pubblico dall’altra. Dall’orientamento delle corti americane degli ultimi anni si può leggere chiaramente il consolidarsi dell’idea che sarebbe molto più opportuno svolgere una simile valutazione comparata in un momento successivo a quello del riconoscimento dell’accordo compromissorio e, cioè, al momento dell’esecuzione della sentenza arbitrale. La tesi che sembra essere alla base di tale orientamento vede quale limite all’arbitrabilità delle controversie non tanto il fatto che la materia oggetto della lite interessi l’ordine pubblico, quanto il fatto che tali esigenze di tipo pubblicistico vengano di fatto disattese da un’infelice soluzione arbitrale; in altre parole, non è il coinvolgimento di interessi superindividuali ma la concreta violazione degli stessi a rendere illegittima la pronuncia dell’arbitro, con la conseguenza che una simile valutazione non potrà che essere effettuata a posteriori, cioè, a procedimento arbitrale svolto e concluso. Pur ritenendo che le implicazioni di ordine pubblico possano eccezionalmente scaturire dalla scelta della sede arbitrale compiuta dalle parti in lite, un eventuale controllo del giudice non potrebbe che essere svolto in sede di esecuzione del lodo e non anche, come nel caso in esame, in sede di riconoscimento dell’accordo compromissorio. In realtà, l’unico motivo invalidante della scelta negoziale della sede non sarebbe tanto la violazione dell’ordine pubblico quanto l’assenza di una negoziazione effettiva della clausola per abuso della maggiore forza contrattuale di una delle parti. Non è molto difficile, tuttavia, dimostrare l’impossibilità per il decidente di censurare sotto questo profilo la scelta delle parti sulla sede arbitrale. La Convenzione non prevede, infatti, tra i motivi per il rigetto l’abuso della maggiore forza contrattuale e poiché tali motivi sono indicati in maniera tassativa è di facile percezione l’esigenza di far rientrare questo motivo specifico di opposizione all’accordo compromissorio tra quelli elencati dalla Convenzione. In realtà nel caso di specie potrebbero rilevare le ipotesi contemplate dall’articolo V, comma I, lettere a) e b), rispettivamente relative all’invalidità della clausola compromissoria in base alla legge che la disciplina e l’effettiva violazione del contraddittorio. Rispetto a quest’ultima ipotesi una tale valutazione potrebbe essere effettuata soltanto ex post, con riferimento, cioè, al lodo che conclude il procedimento arbitrale. Per quanto riguarda il primo motivo, invece, occorre sottolineare come una eventuale invalidità della scelta della sede dovrebbe ricadere sull’intero accordo compromissorio, provocando in tal modo, la decisione del giudice di non rinviare le parti all’arbitro e non anche, come è avvenuto nel caso di specie, di decidere autoritativamente la sede arbitrale, imposta, in I° grado, nel territorio della Florida. Rispetto ad entrambe le ipotesi vale, in ogni caso, la rilevabilità di tali motivi soltanto su eccezione di parte e, pertanto, non avendo la parte interessata sollevato la questione, espressamente, in giudizio, il giudice non può per tale motivo non dare esecuzione alla convenzione di arbitrato.
3) Sentenze che sono già state fatte valere a livello internazionale per il trattato di New York.
Vedi risposta alla domanda 2
4) breve analisi che specifichi come e perché la convenzione di N.Y. sia stata fermamente voluta dall'ONU per dirimere le problematiche tra Stati e cittadini di diverse giurisdizioni.
La Convenzione di New York del 1958 (dicitura integrale: Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere) è un trattato internazionale multilaterale, firmato nell'ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York il 10 giugno 1958, entrato in vigore il 7 giugno 1959 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968 (con efficacia stabilita a partire dal 1º maggio 1969). La Convenzione di New York è stata uno strumento fondamentale a livello internazionale per favorire il riconoscimento delle sentenze arbitrali pronunciate nell'ambito degli Stati firmatari. La procedura in essa prevista rende più facile e veloce l'esecuzione dei cosiddetti lodi arbitrali tra Paesi diversi, riducendo in questo modo il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo stesso. La Convenzione ha imposto agli Stati firmatari di non prevedere, relativamente al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze arbitrali straniere, condizioni più gravose rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali. La Convenzione è attualmente ratificata da 156 paesi.
La Convenzione di New York, che l’Italia ha ratificato senza riserve – provocando, così, l’effetto c.d. erga omnes, cioè anche se la parte soccombente risiede in uno Stato che non è firmatario della Convenzione di N.Y. – riconosce un effetto semi-automatico al lodo estero (salvo il caso dell’opposizione al riconoscimento, di cui all’art. 5 di detta Convenzione). Oggetto principale della Convenzione di New York è quello di garantire una circolazione internazionale dei lodi arbitrali, che rientrino nel suo ambito di applicazione. Dunque, la Convenzione di New York persegue uno scopo essenziale, tenuto conto del monopolio statale dei mezzi di coercizione e dell’aspettativa delle parti di ottenere, attraverso l’arbitrato, un giudizio concretamente efficace. Tale scopo è perseguito con una disciplina, intesa a facilitarne la recezione negli ordinamenti interni, concentrata sulla identificazione dei motivi che la impediscano, da valutare in un quadro procedurale la cui definizione è lasciata agli Stati contraenti (art. III). In particolare, il meccanismo introdotto dalla Convenzione di New York distingue due gruppi di circostanze ostative del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo: nel primo rientrano quelle che sono invocabili solo dalla parte che si oppone (art. V, par. 1); al secondo sono assegnati quelli, il cui ricorrere può essere rilevato d’ufficio (art. V, par. 2). Viene comunque fatta salva la possibilità di riconoscimento o esecuzione sulla base di disposizioni nazionali più favorevoli (art. VII).
6) la applicazione del riconoscimento dello status di personalità giuridica di diritto internazionale, secondo la Convenzione di Montevideo (1933), nelle sentenze degli arbitrati internazionali determinati tra gli Stati sottoscrittori della Convenzione di New York (1958).
La personalità giuridica internazionale – e cioè la capacità di essere destinatari delle norme dell’ordinamento internazionale e titolari dei diritti e degli obblighi in esse contenuti viene riconosciuta principalmente agli Stati.
I tradizionali caratteri dell’indipendenza da qualsiasi altro centro di potere esterno (c.d. sovranità esterna) e della capacità esclusiva di esercitare funzioni di governo su popolo e territorio (c.d. sovranità interna) vengono in considerazione alla luce del criterio di effettività e attribuiscono, secondo la prassi e l’opinione dominanti, la soggettività internazionale agli Stati anche a prescindere da forme di riconoscimento e da considerazioni di legittimità e cioè da valutazioni in ordine alle modalità con le quali si è venuto formando il nuovo Stato, con particolare riguardo al rispetto del principio di legalità.
Tali caratteri sono ben evidenziati nella Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1933 (§ 1.1) che, a prescindere dal suo valore giuridico vincolante per i soli Stati contraenti, contiene all’art. 1 una precisa ricognizione degli elementi considerati necessari e sufficienti per connotare l’esistenza di uno Stato in quanto ente collettivo dotato di personalità giuridica internazionale.
La sussistenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della soggettività internazionale agli Stati è stata valutata dalla Corte di Cassazione in occasione di alcuni procedimenti relativi all’applicazione della norma sulla inviolabilità personale e sull’immunità dalla giurisdizione penale dei capi di Stato, di governo e dei ministri degli esteri di uno Stato sovrano nei confronti di persone ricoprenti cariche pubbliche al vertice di enti diversi. Interessanti, a questo proposito, sono due pronunce in occasione delle quali la Corte, per decidere sul riconoscimento dell’immunità dall’esercizio della giurisdizione italiana nei confronti del presidente del comitato esecutivo dell’OLP (Yasser Arafat) in un caso e del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica del Montenegro (Djukanovic) nell’altro caso, ha dovuto valutare in via preliminare la questione della soggettività internazionale degli enti al cui vertice si trovavano le persone indagate dalla magistratura italiana. Se nel primo caso la Corte si è rifiutata di riconoscere l’immunità all’indagato per la mancanza del criterio di effettività in capo al movimento di liberazione nazionale al cui vertice l’indagato stesso si trovava, nel secondo caso è stata la mancanza del requisito dell’indipendenza a condurre al rifiuto dell’immunità nei confronti del presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica del Montenegro. Si inserisce nella stessa tematica il parere richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’ottobre 2008 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale di indipendenza, proclamata nel febbraio 2008 dal Kosovo nei confronti della Serbia. Il parere della Corte reso il 22 luglio 2010 sembra rispondere tuttavia solo parzialmente agli interrogativi suscitati dalla presa di posizione kosovara.
Allo stato, dunque, non pare possibile individuare la sussistenza di altri requisiti alla luce dei quali attribuire la soggettività internazionale agli Stati; in particolare, non sembra rilevante il rispetto di un principio di legittimità democratica, secondo il quale la scelta dei governanti dovrebbe avvenire da parte dei governati nel rispetto di regole democratiche. Va rilevato che progressivamente, tuttavia, un numero crescente di Stati ha dimostrato di voler rispettare tale principio. Ciò è quanto si è verificato in ambito OSCE, dove gli Stati partecipanti si sono impegnati a garantire lo svolgimento di regolari elezioni che potranno essere monitorate, dietro l’invito dello Stato nel quale le elezioni si devono tenere, da osservatori inviati dall’organizzazione stessa i quali valuteranno l’osservanza delle regole nelle quali si declina il principio di legittimità democratica (alias “autodeterminazione interna”). Sembra tuttavia difficile sostenere che esso assurga al rango di norma consuetudinaria che abbia introdotto un criterio diverso da quello dell’effettività.
Proprio in omaggio al criterio di effettività alla luce del quale si deve valutare la ricorrenza dei requisiti di fatto per l’esistenza dello Stato e, in fondo, anche in considerazione della struttura che si vuole giuridicamente paritaria della Comunità internazionale (v. il Principio di uguaglianza sovrana degli Stati di cui alla Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati), si ritiene comunemente di negare alla prassi del riconoscimento dei nuovi Stati da parte dei predecessori la natura di atto costitutivo della soggettività internazionale, attribuendogli invece un valore giuridico limitato all’effetto meramente dichiarativo.
Dunque il mancato riconoscimento non incide sulla soggettività internazionale di uno Stato che dipende, invece, dall’effettivo esercizio dei poteri di governo su popolazione e territorio.
7) Gli effetti giuridici imprescindibili erga omnes delle sentenze, che trattano i diritti potestativi generali dell'uomo e, in particolare, quello dell'auto determinazione.
Si tratta di esaminare quali sono per il diritto internazionale i titolari del diritto e i depositari dell’obbligo implicati dal principio di autodeterminazione.
La risoluzione di questo problema presuppone naturalmente la determinazione di quali siano i membri della società, nella quale il diritto internazionale si manifesta e opera. Occorre, quindi, preliminarmente accertare quali siano i protagonisti della vita di relazione internazionale.
In base ad una lunga e risalente tradizione, il diritto internazionale disciplina i rapporti tra entità indipendenti e sovrane, ma non è in alcun modo configurabile come ordinamento di una società umana universalmente organizzata. Pertanto, non sembra possa ancora oggi dubitarsi del fatto che tutte le norme del diritto internazionale si indirizzano agli stati e non ai singoli individui né tantomeno ai popoli in quanto tali.
I destinatari dell’obbligo scaturente dal principio di autodeterminazione sono quindi i singoli stati, in quanto membri dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
Per quanto concerne invece il correlativo diritto, non esistono valide ragioni per affermare che esso spetti ai singoli popoli: come già dicevamo prima, il fatto che si parli di “autodeterminazione dei popoli” non è sufficiente per dedurre che i popoli siano effettivamente titolari di questo diritto.
Un’analisi delle vicende storiche potrebbe essere illuminante a riguardo: nel processo di decolonizzazione, i popoli hanno prima dato vita ad entità indipendenti e solo in tale veste hanno condotto la loro lotta di liberazione. In altri termini, i popoli erano meri detentori “reali” delle istanze di autodeterminazione, mentre le entità indipendenti, espressione dei popoli in lotta per ottenere la realizzazione di queste istanze, le hanno concretamente perseguite e realizzate, in quanto soggetti di diritto internazionale, equiparati agli stati.
In definitiva, gli stati membri delle N.U. sono al tempo stesso destinatari dell’obbligo e titolari del diritto all’autodeterminazione. Da un lato, si configura un obbligo, a carico tutti gli stati membri, di rispettare il diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione e di assicurarne per quanto possibile la concreta soddisfazione. Dall’ altro, si pone, in capo a ciascuno di essi, il diritto di pretendere l’osservanza del suddetto obbligo nei confronti degli altri stati.
Una volta riconosciuto il principio di autodeterminazione come oggetto di uno specifico obbligo interstatuale, ne discende come logica conseguenza l’affermazione del carattere direttamente precettivo di tale principio, così come configurato dalla Carta delle Nazioni Unite.
Va segnalato peraltro che non tutti concordano su tale conclusione e in particolare alcuni studiosi propendono per annettere al nostro principio, inserito nella Carta tra gli obblighi umanitari, un valore politico o meramente programmatico, talché ne discenderebbe che esso dovrebbero essere realizzato nel quadro di un cosiddetto “programma d’azione”
articolato e non immediato. A differenza di altri principi, anch’essi contenuti nell’art.2 (divieto dell’uso della forza, regolamento pacifico delle controversie, etc.), i quali invece andrebbero attuati in maniera immediata e “nella loro pienezza”. Questa tesi circa un presunto, mero valore politico-morale del nostro principio non ci sembra possa essere condivisa.
In nessun modo, infatti, la Carta delle Nazioni Unite può essere interpretata come una dichiarazione di principio o dichiarazione di intenti, che dovrebbe ispirare la condotta degli stati nella vita di relazione internazionale.
Anche a voler tacere delle opinioni che ascrivono ad essa un ruolo “costituzionale” o comunque sovraordinato rispetto alle altre fonti nell’ordinamento internazionale, non si può negare che la Carta rappresenti a tutti gli effetti un trattato, che pertanto contiene norme ad efficacia obbligatoria cui gli stati membri debbono adeguare i propri comportamenti. In questo quadro, una delle disposizioni più importanti senza dubbio è rappresentata, insieme con i suoi numerosi corollari, da quella che impone l’obbligo per gli stati di sviluppare relazioni pacifiche tra loro. E uno dei presupposti indefettibili di quest’obbligo è proprio il principio di autodeterminazione dei popoli, di cui agli artt.2 e 55 della Carta.
D’altro canto, l’obbligatorietà del principio che impone di sviluppare relazioni amichevoli non può essere posta in discussione giusta la formulazione degli artt.55 e 56, che non dà adito a dubbi relativamente alla natura vincolante del medesimo e sarebbe irragionevole anche solo ipotizzare che uno dei presupposti di questo impegno sia da considerare discrezionale, in quanto oggetto di un principio politico.
Né sembra possa accogliersi la tesi che configura il principio di autodeterminazione come principio programmatico. Ciò si può affermare, sia sulla base delle ragioni anzidette, sia in considerazione del fatto che lo Statuto delle Nazioni Unite è un trattato internazionale che determina effetti immediatamente obbligatori nei rapporti tra gli stati.
Se si vuole tuttavia sottolineare un aspetto per così dire programmatico nel nostro principio, lo si può cogliere nel fatto che l’obbligo che da esso discende va adempiuto non solo e non tanto sul piano internazionale, ma anche sul piano interno e con scelte operate nel singolo ordinamento statuale. Tuttavia, quest’ultima constatazione, se consente al singolo Stato di scegliere gli strumenti e le forme attraverso cui realizzare l’obbligo imposto dal diritto internazionale (che si configura perciò come obbligo di risultato e non obbligo di mezzi), non può però implicare in alcun modo la concessione di una discrezionalità ulteriore e, in particolare, l’attribuzione ad esso del potere di giudicare unilateralmente l’avvenuto adempimento o meno.
Per concludere, si può quindi affermare che il diritto dei popoli all’autodeterminazione è oggetto di un rapporto obbligatorio solidale tra gli stati in virtù della Carta della Nazioni Unite e di altri trattati internazionali, così come in base al diritto internazionale generale. In virtù di esso, tutti gli stati hanno sia l’obbligo di agire in modo da assicurare a tutti i popoli il diritto ad autodeterminarsi, sia il diritto di pretendere l’osservanza del suddetto obbligo da ciascuno degli altri stati.
I popoli sono quindi i beneficiari del diritto di autodeterminazione. Questo diritto è sancito dunque a beneficio di tutti i popoli, senza alcuna limitazione soggettiva, come si desume dagli artt.1 par. 2 e 55 della Carta.
Si può quindi senz’altro sostenere che ”il popolo” è titolare del diritto all’autodeterminazione?
Questa conclusione è solo un aspetto del più ampio dibattito svoltosi nella dottrina e nella prassi, in ordine alla possibilità di riconoscere ai popoli la personalità giuridica internazionale, attribuendo ad essi la legittimazione ad essere titolari di diritti ed obblighi e tra gli altri innanzitutto del diritto all’autodeterminazione.
In realtà, questa opinione è condivisa solo da una parte degli studiosi della materia ed in particolare da coloro i quali abbracciano la cosiddetta tesi “dei diritti dei popoli”, che partendo dal presupposto per cui “un’istituzione ha senso e ha realtà solo in quanto esprime i bisogni e i diritti del popolo che rappresenta”, sostiene che la funzione che lo Stato esplica nel quadro del diritto internazionale è solo il riflesso del ruolo di rappresentanza del popolo del quale è istituzionalmente investito. A sostegno di questo indirizzo interpretativo, vengono invocate varie pronunce solenni della Comunità internazionale, come lo stesso preambolo della Carta delle Nazioni Unite, che, in nome dei “popoli delle Nazioni Unite”, è stata concordata dai “rispettivi Governi”.
L’introduzione e la valorizzazione nell’ordinamento internazionale del principio di autodeterminazione dei popoli ha contribuito in grande misura ad influenzare questo orientamento. Volendo semplificare, si potrebbe dire che il ragionamento seguito dai sostenitori di questa tesi è il seguente: poiché numerosi atti delle Nazioni Unite attribuiscono ai popoli la prerogativa dell’autodeterminazione, se ne dovrebbe dedurre logicamente che essi debbano essere considerati veri e propri titolari del correlativo diritto.
A questo proposito, nella dichiarazione relativa alla concessione dell’indipendenza ai popoli e ai paesi sottoposti a dominio coloniale, viene ribadito il diritto all’autodeterminazione dei popoli come diritto di determinare liberamente la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
Successivamente, nella dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti i rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli stati in conformità con la Carta della Nazioni Unite, si sostiene tra l’altro che i popoli che reagiscono e resistono a un atto di coercizione nell’esercizio del loro diritto all’autodeterminazione, hanno diritto di ricercare e ricevere un appoggio secondo gli scopi e i principi della Carta. Ancora, va richiamata la dichiarazione relativa alla definizione dell’aggressione, la quale non pregiudica il diritto dei popoli sottoposti a regime coloniale, razzista o ad altre forme di dominio straniero, di lottare ai fini dell’autodeterminazione, libertà e indipendenza, conseguendone di riflesso che l’impiego della forza non costituisce violazione del relativo divieto, se si appalesa come lo strumento per realizzare il proprio diritto all’autodeterminazione.
Possiamo dire, comunque, che le ragioni addotte dai sostenitori di questa tesi non sono del tutto condivisibili e comunque occorre essere molto cauti nell’ avallarne le conclusioni che se portate alle estreme conseguenze comporterebbero una vera e propria rivoluzione nella struttura del diritto internazionale, che è tradizionalmente inteso come diritto di stati, diritto cioè che regola i rapporti tra gli stati e solo tra gli stati.
Inoltre, esaminando approfonditamente i termini della questione, le stesse argomentazioni proposte da coloro che propongono questa soluzione possono tranquillamente essere piegate a sostegno della diversa opinione (peraltro, ancora oggi maggioritaria), che individua il popolo non come titolare, bensì come beneficiario del nostro diritto. Infatti, non è sufficiente la semplice qualificazione dell’autodeterminazione come diritto dei popoli, per conferire ad essi che ne sono ontologicamente privi un certo attributo giuridico: la personalità giuridica internazionale.
A questo riguardo, va sottolineato poi come rappresenti ormai un dato di fatto indiscutibile non un mero postulato teorico, l’asserzione per cui il diritto internazionale è un diritto che regola in tutti i suoi aspetti rapporti interstatuali, per cui sono sempre e solo gli stati i soggetti del diritto internazionale e solo essi sono dotati di personalità giuridica internazionale.
Inoltre, non va trascurato, in questa sede, il riferimento alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, la quale non ha mancato di esaminare in maniera analitica la questione della titolarità del diritto all’autodeterminazione e ha sostenuto in particolare che il nostro principio “risponde alla necessità di rispettare la volontà liberamente espressa dai popoli”. Con ciò, ha voluto porre l’accento sul fatto che i relativi obblighi gravano evidentemente sugli stati, i quali sono tenuti a favorire le istanze di autodeterminazione dei popoli.
A queste considerazioni, si deve aggiungere l’ulteriore complicazione derivante dalla sovente ineffabilità del concetto di popolo e quindi dalla difficoltà di accertarne la sua configurabilità in una data situazione concreta: per quanto astrattamente riconducibile ad una collettività di individui caratterizzata da comunanza di lingua, razza, religione e tradizioni, esso può anche non coincidere con l’insieme degli abitanti di una data entità statuale. Questo può verificarsi essenzialmente per due motivi: o perché due o più popoli hanno dato vita ad un unico Stato, o perché ciascuno di essi non ha potuto costituirsi in Stato autonomo.
Pertanto, si può tranquillamente affermare, cercando di guardare con sufficiente equilibrio al problema in esame, che il popolo, lungi dal costituire un ente dotato di personalità giuridica internazionale, è in realtà configurabile solo come mero oggetto o come materiale beneficiario di norme internazionali che determinano pur sempre diritti ed obblighi in capo agli stati.
Concludendo per ora il nostro discorso, si può solo osservare come il concetto di popolo e l’istituto dell’autodeterminazione siano tra lo ro strettamente interdipendenti, nel senso che si definiscono a vicenda e risultano strettamente correlati al contesto politico-sociale emergente in una data epoca storica.
Ad un esame approfondito della lettera della Carta del 1945, del resto, si può cogliere l’ampia portata del nostro principio, laddove l’art.1 par.2 e l’art.55 parlano, in generale e senza specifiche di sorta, di “uguaglianza dei diritti” e “autodeterminazione dei popoli”.
In realtà, constatare, come abbiamo già fatto in precedenza, che l’autodeterminazione sia stata intesa in una certa fase storica solo in funzione del processo di decolonizzazione, significa cogliere un connotato saliente di essa e cioè la sua “dinamicità” Ad un esame approfondito della lettera della Carta del 1945, del resto, si può cogliere l’ampia portata del nostro principio, laddove l’art.1 par.2 e l’art.55 parlano, in generale e senza specifiche di sorta, di “uguaglianza dei diritti” e “autodeterminazione dei popoli”.
In realtà, constatare, come abbiamo già fatto in precedenza, che l’autodeterminazione sia stata intesa in una certa fase storica solo in funzione del processo di decolonizzazione, significa cogliere un connotato saliente di essa e cioè la sua “dinamicità”.
E questo non comporta altro che l’applicazione di essa alla situazione di estrema violazione emergente in una certa fase storica, quale era senza dubbio l’oppressione di stampo coloniale nel secondo dopoguerra. Né da questo orientamento può dedursi che si intendesse sbarrare per sempre la strada ad una lettura diversa e ulteriore del principio di autodeterminazione, rappresentando in quel momento il raggiungimento dell’indipendenza da parte dei popoli soggetti al giogo coloniale una pre-condizione indispensabile per assicurare lo sviluppo di relazioni pacifiche tra gli stati.
Va detto che questa prima fase dell’attività della Nazioni Unite, in particolar modo incentrata sulla liberazione dei popoli dalla cosiddetta “alien domination”, trova poi espressione significativa nella già citata dichiarazione dell’Assemblea generale relativa alla concessione dell’indipendenza ai popoli e ai paesi sottoposti a dominio coloniale, laddove il principio di cui all’art.1 par.2 viene esplicitato come ”il diritto dei popoli non autonomi e sotto tutela di pervenire all’indipendenza, di determinare liberamente la loro continua condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale”, aggiungendosi poi che il popolo può esercitare il suo diritto all’autodeterminazione ove si trovi sottoposto a dominazione coloniale razzista o straniera.
Peraltro, già prima del 1960, le Nazioni Unite ebbero modo di definire in termini generali il nostro principio, prevedendone con due risoluzioni apposite l’inserimento nel Patto sui diritti dell’uomo ancora in via di definizione, dalle quali peraltro ancora non emerge la fondamentale distinzione tra autodeterminazione esterna ed interna.
Tuttavia, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo non contempla il principio in esame, mentre occorrerà attendere il 1960 e la citata risoluzione per ritrovare un’applicazione concreta dello stesso, sia pure circoscritta al contesto coloniale.
Peraltro, guardando la citata dichiarazione alla luce degli sviluppi successivi dei contenuti del nostro principio, era possibile cogliere tra le sue pieghe un riferimento all’autodeterminazione segnatamente a quella interna, laddove l’art.21, sia pure senza fare riferimenti espliciti all’autodeterminazione, riconosceva ad ogni individuo “il diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti” (par.1) e ” il diritto di accedere a condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese” (par.2), per concludere riconoscendo che “la volontà popolare è il fondamento dell’autorità di governo” e stabilendo che essa” deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente”.
Già poco più tardi, però, l’autodeterminazione non solo fece la sua esplicita comparsa sulla scena del diritto internazionale, ma ricevette nuova linfa attraverso la proposta di inserimento nei due patti sui diritti dell’uomo, che venne sollecitata dai paesi dell’area socialista, i quali la intesero tuttavia in un’accezione strettamente anticolonialista (ossia, liberazione delle colonie dalla madre patria); viceversa le potenze occidentali si batterono per l’approntamento della formulazione più ampia e omnicomprensiva possibile.
Infatti, l’Assemblea Generale adottava un apposito articolo dedicato all’autodeterminazione, concepita al fine, in primo luogo, di preservare le generazioni presenti e future dal flagello della guerra; in secondo luogo, per rinnovare la propria fede nei diritti fondamentali dell’uomo e in ultimo per tenere adeguato conto delle aspirazioni politiche di tutti i popoli.
Così, nel 1966, venivano emanati i due patti, il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici sociali e culturali, entrambi i quali si aprono con un identico articolo che proclama il principio di autodeterminazione, frutto di un dibattito molto vivo nel quale fu alla fine accolta la interpretazione più ampia propugnata in particolare dai paesi occidentali.
L’art. 1 nel par. 1 sottolinea che l’autodeterminazione possiede tanto un contenuto politico, quanto economico sociale e culturale; il par. 2 si concentra, invece, sull’autodeterminazione economica, da intendersi come libera disponibilità da parte di un popolo delle proprie ricchezze e delle risorse nazionale nei confronti degli altri stati, sulla base del principio dell’interesse reciproco già presente nella dichiarazione sulla decolonizzazione; infine, il par. 3 fa riferimento all’autodeterminazione coloniale, in relazione ai territori non autonomi e sotto tutela, in tal modo estendendo il riconoscimento del diritto prima riservato ai popoli sotto dominazione coloniale.
Come già evidenziato in precedenza, è con la fine degli anni ’60 che vengono enucleati i molteplici profili dell’autodeterminazione: non solo quella politica-coloniale, ma anche quella economica, sociale e culturale; non solo quella esterna, ma anche quella interna.
Un significativo passaggio avvenne poi nel 1970, con l’approvazione, da parte dell’Assemblea generale, della dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati dalla quale emerge per la prima volta la opportunità di applicare il nostro principio non solo a situazioni diverse dalla dominazione per mano coloniale, straniera e razzista, ma anche all’ipotesi dell’oppressione di un popolo ad opera del suo stesso governo.
Questo indirizzo espansivo dell’autodeterminazione viene rafforzato poi dalla previsione della c.d. clausola di salvaguardia dell’integrità territoriale degli stati, di cui al par.7 del principio V della dichiarazione su citata. Essa in particolare è preordinata a garantire il mantenimento delle frontiere per gli stati che esprimano un governo rappresentativo del popolo governato e che sia in tal modo rispettoso del principio di autodeterminazione, in quanto non operi rispetto ad esso discriminazione alcuna in ragione della razza, del colore o della fede religiosa.
Nella dichiarazione in parola, si profila, accanto a quello più tradizionale esterno, un contenuto interno dell’autodeterminazione, in quanto nel par.1 del V principio si parla del diritto di tutti i popoli “de determiner leur statut politique, en toute liberté et sans ingerence exterieur, et de poursuivre leur developpement économique social et culturel; et tout etat a le devoir de respecter ce droit conformement aux dispositions de la Charte”.
Insomma, potremmo concludere evidenziando come con la succitata risoluzione, si fa strada, nell’ordinamento internazionale, l’esigenza inderogabile che tutti i governi siano designati con meccanismi democratici disposti dal popolo da essi guidato.
Questo postulato può essere proclamato in quanto è anch’esso espressione diretta del principio di autodeterminazione.
La emersione nel diritto internazionale di una interpretazione più “generosa” del principio di autodeterminazione si determina in misura significativa nell’VIII principio del decalogo approvato dalla Conferenza di Helsinki. Esso è in particolare contenuto nell’Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa(CSCE), firmato a Helsinki nel 1975, in forza del quale gli stati firmatari (31: stati dell’Europa occidentale e orientale, più Stati Uniti d’America, Canada, Turchia e Santa Sede) si sono impegnati a rispettare i dieci principi in esso enunciati, tanto nei rapporti reciproci, quanto nei confronti degli stati terzi estranei alla CSCE.
Dopo la generale proclamazione del primo paragrafo, nella quale viene riaffermata l’obbligatorietà del nostro principio (“Gli Stati partecipanti rispettano l’eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite”), il secondo paragrafo è emblematico di una lettura evolutiva del medesimo, in quanto riconosce ad esso una valenza dinamica e così consente che il diritto all’autodeterminazione possa venir esercitato da ciascun popolo in modo permanente (“tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime interno ed esterno...”) e perciò stesso esclude che esso continui ad essere confinato a svolgere una funzione meramente anticolonialistica, mentre il terzo paragrafo ne riafferma infine la valenza universale (“Gli Stati partecipanti riaffermano l’importanza del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell’autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro”).
In tal modo, viene riconosciuto ad ogni popolo il diritto di determinare in ogni momento il proprio regime politico interno ed esterno.
Questo implica poi a sua volta non solo il riconoscimento della legittimità dell’aspirazione a conseguire e mantenere l’indipendenza politica economica e sociale nei confronti degli altri stati, ma altresì del diritto di scegliere in maniera autonoma il regime politico economico e sociale da applicare sul piano interno e quindi di una pretesa da rivendicare nei confronti di qualsiasi governo o partito al comando.
Va segnalato tuttavia che alcuni autori hanno ridimensionato notevolmente la carica innovativa di questa disposizione e ravvisato quale unico obbiettivo dell’Atto in esame quello di dare una sanzione solenne e definitiva alle frontiere territoriali politiche e ideologiche risultanti dalla seconda guerra mondiale e dai suoi sviluppi più immediati.
Questa tesi restrittiva ha fatto leva principalmente sulla constatazione che in esso sono stati inclusi anche altri principi intesi come meramente conservativi dello stato di fatto esistente al momento della sottoscrizione del documento in esame (status quo).
In particolare, questi autori hanno richiamato a titolo di esempio il principio dell’integrità territoriale (III) e quello dell’inviolabilità delle frontiere (IV), che pur venendo intesi fino ad allora come meri corollari del principio che fa divieto agli stati di ricorrere all’uso o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali, acquisiscono in questa sede un valore precettivo autonomo e vengono collocati in un
a posizione di rilievo, immediatamente dopo il principio di uguaglianza sovrana degli stati (I) e quello del divieto dell’uso della forza (II).
Per completare il quadro, basterebbe poi fare cenno al principio di non intervento (VI), così da far capire come sia forte nell’Atto di Helsinki l’esigenza della conservazione della situazione preesistente.
In realtà, è preferibile adottare il metodo sistematico nell’esame di questa fonte normativa, cosicché se da un lato è innegabile ricondurre ad essa la funzione di consacrazione dello status quo risultante nell’Europa centrale e orientale dagli esiti del secondo conflitto mondiale, non però è fuori luogo rimarcare che l’errore consiste nel vedere tale funzione come esclusiva, tralasciando di prendere in considerazione altri principi che operano in direzione opposta a questa.
In questa prospettiva, i principi di “conservazione” succitati (quello dell’integrità territoriale, quello dell’inviolabilità delle frontiere, quello del non intervento), per quanto possano avere un ruolo fondamentale nell’economia dell’Atto in esame, non possono che essere interpretati alla luce del principio dell’autodeterminazione dei popoli (VIII) e così pure alla luce del principio sui diritti umani (VII).
Con ciò possiamo sottolineare come porre l’accento sul nesso di correlazione esistente tra le due categorie di valori e principi sia funzionale al riconoscimento del ruolo dinamico che il nostro principio riveste in quest’Atto.
Invero, la necessità di una lettura sistematica dei principi “umanitari” e “dinamici” da un lato e di quelli conservativi dall’altro, è imposta dal paragrafo delle clausole generali dell’Atto laddove si chiarisce che “tutti i principi sopra enunciati sono di importanza fondamentale e di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri”.
Pertanto, l’obbligo posto a carico di ogni Stato di rispettare l’integrità territoriale e le frontiere di ciascuno degli altri stati incontra un limite invalicabile, al pari dell’obbligo di non intervenire e di non fare uso della forza, nell’esigenza di rispettare le scelte dei popoli e i diritti dell’uomo. Con la conseguenza fin troppo ovvia che ove la preservazione dell’integrità di uno Stato si risolvesse nella lesione della volontà di un popolo o di più popoli, ne discenderebbe che l’intensità del primo obbligo verrebbe ad essere attenuata dalla necessità di rispettare l’autodecisione dei popoli stessi (rectius, autodeterminazione).
Occorre peraltro sottolineare che il contemperamento di queste due esigenze contrapposte non potrebbe spingersi fino al punto di calpestare del tutto una di esse e per questa via legittimare ad esempio un intervento armato di uno stato terzo che violasse i confini dello Stato responsabile della violazione “umanitaria”, ma varrebbe a consentire al più l’adozione di risoluzioni di sostegno alla causa del popolo oppresso o anche misure di pressione più impegnative sul piano economico e politico ad opera di organismi internazionali a ciò deputati, come anche la espressione di prese di posizione pubbliche a favore del medesimo popolo da parte di stati terzi.
Si può quindi concludere su questo punto dicendo che, alla luce dell’Atto Unico di Helsinki, il rispetto della situazione politica e dei confini dei singoli stati non può prescindere dalla tutela dei diritti umani e in primo luogo del diritto dei popoli all’autodeterminazione, sul presupposto che la adeguata protezione di questi ultimi costituisce una condizione essenziale per lo stabilimento di relazioni pacifiche e di proficua collaborazione tra i membri della società internazionale.
Già nel 1990, in un quadro internazionale profondamente mutato dal punto di vista politico e ideologico, la conferenza per lo sviluppo e la cooperazione in Europa (CSCE) è ritornata su questi temi e ha adottato la “Carta di Parigi per una nuova Europa”, sottoscritta da tutti gli stati partecipanti il 21 novembre 1990.
Nella Carta, un notevole spazio viene riservato al principio di autodeterminazione, attraverso non solo la sua formale riaffermazione in ossequio alla Carta delle Nazioni Unite, ma anche con la previsione esplicita dell’impegno a sviluppare relazioni tra gli stati improntate al rispetto della libertà di scelta di ciascun soggetto. Del resto questa considerazione viene accompagnata poi dalla sottolineatura che la sicurezza è indivisibile e la sicurezza di ogni Stato è inseparabilmente connessa con quella di tutti gli altri.
Il successivo passaggio di questo processo acquisitivo delle potenzialità ancora inespresse del principio di autodeterminazione si può cogliere nella quarta riunione dei Seguiti tenutasi a Helsinki dal 24 marzo all’8 luglio del 1992.
Importante si rivela poi la presa d’atto che sono state “le aspirazioni dei popoli a determinare il loro status politico interno ed esterno”, come pure “a condurre alla diffusione dei principi democratici e a permettere la nascita di nuovi stati sovrani” come espressione di quelle istanze. Mentre dunque si pone l’accento sull’autodecisione dei popoli, viceversa viene meno qui ogni riferimento ai principi dell’integrità territoriale e dell’intangibilità delle frontiere.
Per la verità, il clima in cui si svolse tale conferenza non fu propriamente sereno, per via delle nuove divergenze emerse tra gli occidentali e la federazione russa in ordine all’opportunità di escogitare una formulazione che contenesse riferimenti tanto al nostro principio, quanto alla tutela dell’integrità territoriale, sulla scorta della originaria disposizione dell’Atto finale di Helsinki. In questa prospettiva, fu avanzata la proposta di inserire nella dichiarazione un passaggio in cui accanto alla consacrazione del diritto all’autodeterminazione, si precisasse che esso non comporta ipso iure un diritto all’indipendenza e si sottolineasse d’altro canto che la necessità del rispetto dello status quo non preclude mutamenti territoriali che si realizzino sulla base di negoziati e mediante l’accordo degli stati coinvolti.
Pertanto, benché la complessità del momento storico vissuto dall’Europa e la stessa genesi dei conflitti che infiammavano il vecchio continente affondassero le radici proprio nel secolare e irrisolto dilemma tra i due principi e pertanto fosse quanto mai auspicabile una presa di posizione inequivoca in merito da parte degli stati, proprio la prossimità di queste turbolenze di fatto impedì il raggiungimento di una posizione equilibrata e condivisa da tutte le parti in causa.
Non si può però dimenticare che nel medesimo testo viene riaffermata la validità dei principi e dei valori risalenti all’Atto finale di Helsinki e alla Carta di Parigi, dove appunto trovano spazio anche i principi “conservativi” della integrità territoriale e dell’inviolabilità delle frontiere, con la conseguenza che la necessità della loro osservanza non è venuta meno per effetto dell’atto in esame.
Tenteremo a questo punto di rispondere in maniera più argomentata ad un quesito che potrebbe apparire in buona misura retorico, ma ciò sarà utile al fine di cogliere i passaggi evolutivi essenziali attraverso cui abbiamo potuto giungere a certe conclusioni.
In particolare, occorre esaminare in quale misura il principio di autodeterminazione politica possa essere inteso, oltre che nel senso più tradizionale di autodeterminazione esterna (rectius, ius secessionis), anche come autodeterminazione interna.
Come abbiamo già detto, nel primo caso, si parla di autodeterminazione per riferire del diritto di un popolo sottoposto a dominio straniero di sottrarsi a tale condizione di soggezione per dare vita ad uno stato indipendente od integrarsi con uno stato terzo preesistente, mentre la nozione di autodeterminazione interna a dire il vero appare più problematica e ad essa non sempre dottrina e prassi internazionale attribuiscono significati univoci e concordanti.
Di volta in volta, si parla di essa come del diritto di un popolo a scegliere la forma di governo e il regime politico dello Stato di appartenenza e quindi a non essere sottoposto ad un regime dittatoriale e di avere un governo democraticamente scelto; oppure, con riferimento alle minoranze o ai popoli inglobati in stati multietnici, ci si riferisce al loro diritto di disporre di adeguati margini di autonomia e di autogoverno atti a tutelarne e preservarne l’identità; infine, se ne parla anche a proposito del diritto dei popoli costituitisi in Stato a decidere del proprio destino, senza interferenze esterne da parte di chicchessia, siano essi stati terzi o organizzazioni internazionali (ossia, in pratica, il divieto di ingerenza negli affari domestici del singolo Stato).
Si può affermare, in linea di massima, che la concreta esplicazione di questi aspetti dell’autodeterminazione non comporta la nascita e l’estinzione di soggetti del diritto internazionale o l’associazione e l’integrazione con un diverso stato, né mutamenti apprezzabili relativamente agli elementi c.d. materiali di due o più soggetti internazionali.
Essa comporterà al più cambiamenti concernenti la vita interna di un determinato Stato e segnatamente le strutture politiche e istituzionali da cui esso è contraddistinto, risolvendosi in pratica in un nuovo modo di essere e di rapportarsi del medesimo con la collettività che ad esso afferisce.
Sotto questo profilo, è emblematico l’art.1 par.1 comune ai due patti internazionali sui diritti dell’uomo del 1966, che così dispone: ”Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux memes. En vertu de ce droit ils determinent librement leur statut politique et assurent librement leur development economique,social e culturel”.
In sede di commento di questa disposizione, come già abbiamo detto, va segnalato incidentalmente che proprio in virtù della sua inclusione nel patto, l’autodeterminazione entra a fare parte della tematica dei diritti umani, che è materia oggetto di diritto interno.
Talché si sarebbe tentati di dire che essa almeno nella versione qui in esame non dovrebbe rientrare a stretto rigore nel nostro studio, se non fosse che più in generale la materia dei diritti umani ha cessato di essere oggetto del dominio riservato dei singoli stati per divenire eminente oggetto di considerazione e attenzione da parte del diritto internazionale.
Vi è poi da sottolineare che l’evoluzione successiva delle fonti normative ha favorito l’emersione di spunti interessanti in materia di autodeterminazione interna, in modo da consentirne una lettura o una interpretazione “democraticamente orientata”, la quale si traduce in buona sostanza nella necessità che i governanti siano scelti dai governati mediante libere elezioni, ispirate ad un metodo pluralistico, che assicuri costantemente la corrispondenza della volontà governativa a quella espressa con il voto popolare.
Un significativo passaggio nella enucleazione della dimensione interna dell’autodeterminazione si può ravvisare senz’altro nella più volte citata risoluzione sulle relazioni amichevoli del 1970, che si colloca nella fase storica successiva alla conclusione del processo di decolonizzazione; fase propizia per l’emersione di un’ottica diversa nell’applicazione del principio di autodeterminazione, non più limitata ad una dimensione interstatuale, ma operante nella vita interna degli stati. Già nel primo paragrafo, il nostro diritto viene emblematicamente definito come il diritto di tutti i popoli “de determiner leur statut politique, en toute liberté et sans ingerence exterieur, et de pursuivre leur developpement economique, social e culturel: e tout Etat a le devoir respecter ce droit conformement aux dispositions de la Charte”.
Così, in forza del dettato di questa disposizione, il principio può giovare ai popoli che lamentino situazioni di oppressione operate dal loro stesso governo, il quale porti avanti politiche di violazione grave e sistematica dei diritti umani e in primo luogo di quel diritto umano che rappresenta il presupposto e il corollario indispensabile per assicurare il godimento dei singoli diritti individuali: cioè, il diritto del popolo medesimo ad autodeterminarsi, inteso appunto nel particolare senso di diritto ad avere un governo rispettoso dei diritti dei governati. Il che trova poi conferma nel fatto che la “rediviva” clausola di salvaguardia dell’integrità territoriale (V principio par.7 della dichiarazione) opera solo nell’ipotesi in cui il governo sia effettivamente rappresentativo dei governati, in quanto non operi alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, la fede o il colore.
Né va dimenticata la dichiarazione sulla definizione di aggressione del 1974, la quale sebbene a causa del particolare argomento da essa affrontato non contenga riferimenti espliciti all’autodeterminazione interna, non solo richiama tutte le varie forme di lotte dei popoli “privés par la force” del loro diritto all’autodeterminazione mediante un rinvio alla dichiarazione sulle relazioni amichevoli, ma soprattutto trova applicazione, oltre che nelle lotte dei popoli sottoposti a dominazione coloniale e razzista, in quelle dei ”peuples qui sont soumis à d’autres formes de domination étrangère”, i quali hanno diritto altresì “de lutter à cette fin et de recevoir un appui”.
Bisogna arrivare però all’Atto finale di Helsinki, firmato dai paesi CSCE nel 1975, perché (principio VIII) l’autodeterminazione interna riceva una esplicita sanzione, come dimensione ulteriore del principio di autodeterminazione rispetto a quella esterna.
D’altro canto, nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che l’autodeterminazione sia qui presa in considerazione nella duplice accezione appena considerata, anche perché il fatto che tale atto sia stato elaborato e adottato con riferimento al contesto europeo, caratterizzato in linea di massima da stati tutti indipendenti e sovrani, depone per una interpretazione delle sue disposizioni orientata innanzitutto a favore dei popoli dei singoli stati, con un’accentuazione della dimensione interna del principio di autodeterminazione.
Possiamo quindi agevolmente sostenere che da questo atto emerge in maniera inequivoca che i beneficiari del diritto di autodeterminazione non sono i singoli stati costituiti, ma innanzitutto i popoli da essi governati.
L’Atto finale si rivela poi importante anche sotto un altro punto di vista, poiché lascia intravedere una valutazione del principio di autodeterminazione non meramente “statica”, ma piuttosto orientata in termini dinamici e intesa quindi come riconoscimento della libertà di ciascun popolo di esercitare in modo permanente il diritto in questione (“Tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime interno ed esterno...e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale”). In pratica, quest’ultimo deve potere esercitare in ogni momento il diritto alla libera scelta tanto in ordine alla sua collocazione internazionale, quanto in merito al proprio sistema politico, economico, sociale e culturale.
Nella prospettiva di analisi qui intrapresa, merita una particolare considerazione anche la già citata “Dichiarazione sui diritti dei popoli” adottata ad Algeri nel 1976 da un gruppo di esponenti politici e studiosi e promossa dalla Fondazione Lelio Basso, che contiene significative disposizioni in materia di autodeterminazione, le quali, sia pure nel contesto di un atto di natura privata, contribuiscono in maniera apprezzabile a chiarire il contenuto del principio.
Accanto alla più tradizionale autodeterminazione esterna, coloniale e razzista (art.5-6), infatti, compare quella interna, espressa nella garanzia che ogni popolo possa godere di un regime democratico e rappresentativo della intera collettività (art.7).
In particolare, gli artt. 5 e 7 delineano un panorama completo del principio, sancendo il diritto permanente di tutti i popoli a disporre di sé stessi, tanto quello esterno dei popoli sottoposti a dominio coloniale, quanto quello interno dei popoli metropolitani, tanto di quelli del Nord e del Sud, quanto di quelli dell’Est e dell’Ovest.
Da ultimo, va esaminato in maniera specifica un altro atto normativo, la Carta dei diritti dell’uomo di Banjul, adottata a Nairobi nel 198, che è oltretutto emblematica dell’atteggiamento dei paesi del terzo mondo verso le problematiche dell’autodeterminazione esterna e interna.
Essa, al contrario della Carta istitutiva dell’Unità Africana, che non contiene alcun riferimento al nostro principio e anzi proclama incondizionatamente quello della sovranità e dell’integrità territoriale, dedica grande attenzione ai diritti umani e nella specie al diritto all’autodeterminazione, nelle sue diverse articolazioni (politica, sociale, culturale, economica, sia interna che esterna).
Se questo è il quadro normativo di riferimento, va notato, tuttavia, che non mancano in dottrina isolate voci critiche in ordine alla possibilità di configurare una dimensione interna del nostro principio e che particolarmente ne rifiutano la lettura “democraticamente orientata”, a cui abbiamo fatto cenno. Questa tesi esclude che costituisca un imperativo del diritto internazionale quello per cui i governi costituiti debbono godere del consenso dei rispettivi popoli e si fonda sul tradizionale assunto che il diritto internazionale ha ad oggetto i rapporti tra gli stati e non può spingersi sino a decidere della loro conformazione. Essa d’altronde trova piena conferma nel dato fattuale per cui ancora oggi e nonostante le solenni dichiarazioni di principi sopra esaminate, la società internazionale comprende un numero considerevole di stati che non sono democratici o che comunque non rispettano pienamente le condizioni previste dal diritto internazionale dei diritti umani, i quali, purtuttavia, sono sostenuti dalla società internazionale e, in ogni caso, intrattengono stabili relazioni diplomatiche con gli stati democratici.
Al di là di queste considerazioni, non sembra, però, ragionevole accogliere questa visione minimalista del principio di autodeterminazione e restringerne la portata ad una dimensione meramente anticolonialista nella quale era stato relegato fino ai primi anni ’60 del secolo scorso.
Sembra più corretto, invece, tenere conto delle diverse fonti internazionali anche non vincolanti più recenti e quindi dei cambiamenti che esse hanno determinato negli atteggiamenti e nelle esigenze degli attori della comunità internazionale, per proporre una interpretazione dinamica e aperta ad una evoluzione continua del principio di autodeterminazione.
Certamente, come già abbiamo avuto modo di dire, l’accoglimento di una tale tesi evolutiva dell’autodeterminazione non può però condurre a legittimare indiscriminati processi di smembramento degli stati esistenti e a determinare un rivolgimento degli equilibri politici consolidati, per dare voce esclusivamente al nostro principio. In proposito, una indicazione illuminante è rinvenibile in un passaggio della più volte citata dichiarazione sulle relazioni amichevoli, laddove si afferma che:”Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign an indipendent States conducting themselves in compliance with principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government rappresenting the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour”.
Naturalmente, come ben chiarisce la lettera della disposizione appena esaminata, tale limitazione potrà operare solo a condizione che il governo possa considerarsi rappresentativo del popolo da esso governato, in quanto non operi discriminazioni in ragione della razza, del credo o del colore. In tal modo, essa stabilisce una presunzione di conformità della volontà popolare con quella governativa, il che vale a dire che il principio di autodeterminazione deve ritenersi rispettato nell’ipotesi di un regime che sia rappresentativo dell’intero popolo. Questa conclusione vale fino a prova contraria, ossia fino a quando non si manifestino sintomi dell’esistenza di un difetto o di una carenza in tale carattere rappresentativo. In definitiva, pur alla luce della recente evoluzione del diritto e della prassi internazionali, che è venuta delineandosi nel senso di un sempre più ampio riconoscimento del principio di autodeterminazione, rimane fermo quanto già indicato in precedenza: il principio del rispetto dell’unità politica e dell’integrità territoriale di ogni Stato rappresenta sempre un limite generale e inderogabile all’esercizio del diritto all’autodeterminazione.
Il principio di autodeterminazione nasce, nel contesto rivoluzionario francese e americano, come un principio squisitamente politico e viene inteso, per tutto il secolo XIX fino alla prima guerra mondiale, come principio di nazionalità, al quale non faceva riscontro alcun obbligo di natura giuridica gravante sugli stati e implicante il riconoscimento del diritto in capo ai singoli popoli.
Solo a seguito del secondo conflitto mondiale e su impulso dei tragici avvenimenti che lo contrassegnarono, tale principio conobbe una maggiore diffusione e si consolidò sul piano strettamente giuridico, attraverso la sua consacrazione nella Carta di San Francisco. In tal modo, il principio di autodeterminazione divenne dunque una norma di diritto internazionale pattizio, fonte di diritti e di obblighi ma solo ed esclusivamente per gli stati firmatari e quindi membri delle Nazioni Unite.
Ciò che si evince in maniera indiscutibile dalla Carta delle Nazioni Unite e segnatamente dagli artt.1 par.2 55 e 56, come già sottolineato, è proprio il fatto che esso qui non ha più semplicemente un mero valore programmatico e una valenza esclusivamente politico-morale, ma diviene un vero e proprio principio giuridico positivo, che deve essere rispettato da tutti gli stati a pena di responsabilità per la violazione della Carta. In altre parole, le previsioni della Carta comportano, senz’altro, il riconoscimento in capo a ciascun Stato membro di un obbligo di rispettare il diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione, e di converso del diritto di pretendere da parte degli altri stati l’osservanza di tale principio.
La questione che in questa sede intendiamo porci è però un’altra e, più precisamente, si tratta di stabilire se tale principio sia da considerare oggi un principio di diritto internazionale consuetudinario o una norma di diritto internazionale generale che possa farsi valere nei confronti di tutti gli stati membri della comunità internazionale (anche non membri delle Nazioni Unite) e in caso di esito positivo cercare di ripercorrere l’iter attraverso cui si è arrivati a tale acquisizione.
Prima di tutto, vi sono una serie di riflessioni che possono farsi e che confermano la tesi ormai maggioritaria che depone per l’ingresso del principio nell’alveo del diritto internazionale generale (rectius, consuetudinario). Costituendo l’autodeterminazione, alla stregua della Carta delle Nazioni Unite, uno dei presupposti dal cui assolvimento dipende lo sviluppo di relazioni pacifiche tra i membri dell’organizzazione, la logica conseguenza non può che essere quella per cui essa è una condizione altrettanto indispensabile per assicurare relazioni pacifiche anche al di fuori della cerchia delle Nazioni Unite, proprio in ragione della sua composizione pressoché universale.
Questo argomento puramente logico è supportato dalle ragioni storiche che hanno portato a sancire il principio, le quali non possono non avere incidenza anche sul contenuto del diritto internazionale generale. Così, per fare un solo esempio, sarebbe impensabile che il processo di decolonizzazione abbia influito in maniera così rilevante nell’azione delle Nazioni Unite e ne sia stato a sua volta condizionato e non abbia, invece, minimamente inciso sui contenuti del diritto internazionale generale, rivoluzionandoli.
In questo senso, se tale principio dovesse ritenersi di natura esclusivamente pattizia, non si comprende come mai, tra i destinatari (e non solo beneficiari) del principio di autodeterminazione, siano da lungo tempo annoverati i movimenti di liberazione nazionale, che non sono parti né della Carta delle Nazioni Unite né dei patti sui diritti umani, così come non sarebbe facile rinvenire un diverso e idoneo fondamento alla base di tale riconoscimento.
Peraltro, va dato atto anche che vi sono taluni che escludono tale metamorfosi del nostro principio, i quali motivano tale opinione contraria sulla base del fatto che tale trasformazione non solo sarebbe contraddetta dall’assetto attuale del sistema delle relazioni internazionali, ma verrebbe messa in discussione dall’interpretazione restrittiva che per lungo tempo è stata impressa alle disposizioni della Carta in materia di autodeterminazione. E a tale proposito appare senz’altro rispondente alla realtà la considerazione che un’applicazione parziale ha rallentato tale processo di estensione dell’operatività del principio, ma sarebbe irragionevole ricavare da tale interpretazione restrittiva una modifica irreversibile del contenuto dell’autodeterminazione. In realtà, l’ostacolo che si vorrebbe frapporre al “travaso” del nostro principio dal diritto pattizio al diritto consuetudinario è il frutto di un pregiudizio di alcuni osservatori che guardano alla prassi delle Nazioni Unite con buone dosi di superficialità e sono pronti a dichiarare la desuetudine di norme della Carta non appena esse vengano disapplicate in tutto o in parte. Dunque, questa posizione non vale a smentire il carattere universale del principio di autodeterminazione.
Numerosi studiosi concordano con la tesi sostenuta e riassumono il processo storico di acquisizione del principio di autodeterminazione al diritto internazionale generale in tre fasi principali: in primo luogo, vengono presi in considerazione a tal fine la Carta delle Nazioni Unite e i Patti sui diritti dell’uomo, che si caratterizzano per una apertura pressoché universale verso il principio di autodeterminazione; in secondo luogo, si è focalizzata l’attenzione sulla volontà politica degli stati, manifestata attraverso l’adozione di numerose risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che hanno contribuito in maniera determinante a sancire la obbligatorietà generale del principio mediante la conformazione
ad esse dell’azione dei singoli stati; infine, si è posto l’accento sul fatto che il principio di autodeterminazione si è arricchito di caratteristiche specifiche per cui la sua realizzazione non dipende solo da comportamenti degli stati rilevanti sul piano internazionale, ma anche e innanzitutto dalle scelte operate da essi sul piano interno e in definitiva dal modo di essere del singolo ordinamento statuale.
Al di là di queste sfumature che colgono aspetti indubbiamente significativi della vicenda storica del nostro principio, quel che deve rimarcarsi è che esso ha acquisito carattere consuetudinario sulla base di una prassi costante che si è affermata in seno alle Nazioni Unite e le cui basi normative possono rintracciarsi in primo luogo nella Carta delle Nazioni Unite; di seguito, essa si è consolidata attraverso le varie dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale, come quella sull’indipendenza dei popoli coloniali del 1960 e quella sulle relazioni amichevoli del 1970, che pur prive di valore normativo hanno concorso in maniera significativa a diffondere le molteplici implicazioni
dell’autodeterminazione. Né a questo processo è rimasta estranea la Corte internazionale di giustizia, che ha riconosciuto con vari pareri resi all’Assemblea generale la natura ormai consuetudinaria del nostro principio: si segnalano in particolare quello relativo al caso della Namibia (1971) e quello in ordine al caso del Sahara occidentale (1975).
Inoltre, va richiamata la sentenza pronunciata nel 1995 dalla medesima Corte in merito alla vicenda che ha visto contrapposti il Portogallo e l’Australia sulla sovranità dell’isola di Timor Est dove l’autodeterminazione viene definita “one of essential principles of contemporary law” e si sottolinea che esso ha efficacia “erga omnes”. Il percorso di universalizzazione del principio in esame è dunque compiuto.
La dottrina internazionalistica prevalente propende per un ulteriore passaggio sempre attinente alla natura giuridica del nostro principio, che comporterebbe il riconoscimento non solo della natura consuetudinaria dell’autodeterminazione, ma l’attrazione dello stesso nella cerchia ristretta dei principi fondamentali del diritto internazionale, o (il che è poi lo stesso) nell’ambito del jus cogens.
Tuttavia, questa ulteriore qualificazione del nostro principio non può essere acriticamente accolta, ma richiede qualche ulteriore precisazione, anche perché regna da sempre notevole incertezza sulla vexata quaestio della natura del jus cogens e in particolare sul rapporto intercorrente tra esso e gli obblighi internazionali cosiddetti erga omnes.
Con quest’ultima espressione, si designano, infatti, quegli obblighi che in quanto derivino da consuetudine o da trattato multilaterale costituiscono obblighi simultanei nei confronti di tutti gli stati, o nei confronti di tutti quelli che sono parti al trattato, con la conseguenza che un’eventuale loro violazione dà luogo a responsabilità nei confronti di tutti coloro che sono
destinatari dell’obbligo, sia esso consuetudinario o pattizio e che i medesimi possono pretenderne reciprocamente l’osservanza nei confronti di ciascuno degli altri stati.
E sotto questo profilo non è difficile riconoscere che l’autodeterminazione rientra perfettamente in tale schema concettuale, in quanto da essa discende da un lato un obbligo a carico di tutte le parti ai trattati che sanciscono questo principio un obbligo generale avente tale contenuto e dall’altro a favore delle stesse un diritto a vederlo rispettato.
Questione diversa è invece se il nostro principio debba farsi rientrare nella categoria del jus cogens.
Allo jus cogens, infatti, si sogliono ricondurre comunemente quelle norme che costituiscono, nel loro insieme, la condicio sine qua non della pace e della sicurezza internazionali. E’ la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati a occuparsi di questo discusso concetto, quando dopo avere sottolineato che “è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con un a norma imperativa del diritto internazionale generale”, afferma che ai fini della medesima convenzione per norma cogente (rectius, imperativa) deve intendersi “una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una nuova norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere” (art.53).
La medesima convenzione ritorna a lambire la nozione di jus cogens con una norma in materia di estinzione dei trattati(art.64), dove si prevede che “se una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale sopravviene, ogni trattato esistente che è in contrasto con questa norma di viene nullo e prende fine” e ancora in un’altra disposizione (art.66), che devolve la risoluzione delle controversie relative alla interpretazione e all’applicazione degli articoli in materia di diritto cogente alla Corte internazionale di giustizia, confermando la complessità e la ineffabilità della materia e conferendo a tale organo giudiziario” una discrezionalità talmente estesa da farne un legislatore internazionale”.
In questo quadro piuttosto avaro di indicazioni risolutive, è possibile tuttavia ancorare la discussione a due punti fermi: in primo luogo, un elemento indicativo della natura cogente di una norma è dato dal carattere generale della medesima e inoltre è determinante il fatto che essa sia riconosciuta e accettata come tale dalla comunità internazionale degli stati nel suo insieme.
E’ così a questo punto possibile, in base alle elaborazioni della dottrina e alle pronunce della giurisprudenza internazionali, tirare le fila del ragionamento osservando che le norme cogenti si qualificano per la forza e la determinazione con le quali sono percepite dai membri della comunità internazionale e dunque per il fatto che finiscono per imporsi autoritativamente nella società internazionale; a queste considerazioni è di conseguenza doveroso aggiungere che esse sotto il profilo del procedimento formativo sono istantanee e non presuppongono dunque un processo acquisitivo di lunga durata; infine, si può concludere avvertendo che tale loro particolare intensità giuridica si traduce nella ovvia conseguenza che le norme di jus cogens non sono abrogabili nè derogabili o modificabili se non da disposizioni di natura equivalente.
Sulla base di quanto appena detto, possiamo subito cogliere quello che è il principale discrimine tra una consuetudine flessibile e una cogente: per la prima, l’elemento essenziale per identificarla è quello oggettivo e di durata, della diuturnitas; per la seconda, viceversa, il rapporto è invertito e dunque determinante per la sua formazione è il dato soggettivo del giudizio e della percezione che di essa ne ha la comunità internazionale, ossia l’opinio iuris seu necessitatis.
Sul piano materiale, il diritto cogente o jus cogens che dir si voglia, si caratterizza per il fatto di incarnare i convincimenti e i valori fondamentali che dal punto di vista etico politico e morale informano la vita di relazione internazionale. Per cui lo strumento normativo al quale si può ricorrere per individuarlo non può che essere innanzitutto la Carta di San Francisco.
Ed in effetti l’art.103 di tale articolato normativo prevede che gli obblighi in base ad esso assunti dagli stati prevalgano sugli obblighi di altra natura e origine. Esso recita infatti che “in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente statuto”. Il che risulta poi confermato dalla prassi internazionale che da sempre ha ritenuto i principi e i valori della Carta intangibili e indisponibili e quindi gerarchicamente sovraordinati rispetto a qualsiasi altra norma pattizia o consuetudinaria del diritto internazionale.
Sotto questo profilo, non possiamo adombrare dubbi sul fatto che tra le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite che rientrano nella previsione dell’art.103 vi è il principio di autodeterminazione. Volendo poi articolare meglio il discorso, deve dirsi che tale principio, come disciplinato dall’art.1 par.2 55 e 56, almeno in alcune delle sue più significative applicazioni (sicuramente, nel caso del dominio coloniale razzista e straniero, come pure nel caso di un regime che attui una politica di sistematica violazione dei diritti elementari dell’uomo), costituisce l’oggetto di un obbligo non solo erga omnes, ma anche cogente, poiché trova la sua ragion d’essere nella tutela di interessi fondamentali della società internazionale, in quanto protetti a loro volta da norme imperative.
Avv. Stefano Linares
100 Park Avenue, Suite 1600 - New York, NY 10017
Piazza 5 Giornate, 10 - 20149 Milan, Italy
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Website: www.linareslaw.com